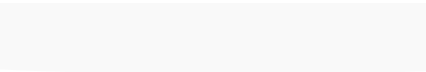Il Giro del mondo in un sentiero
San Benedetto del Tronto | Riportiamo integralmente la relazione tenuta dal prof. Renato Novelli in occasione della "Festa dei funai". Un interessante excursus che tocca gli aspetti antropologici, sociali ed economici dell'antico mestiere del funaio.
di Renato Novelli

(da sinistra) Il prof. Renato Novelli espone la sua relazione. Accanto a lui Domenico Nico e Benedetta Trevisani
Il Giro del mondo a cui allude il titolo, non è quello molto noto in 80 giorni e neppure la meno nota, ma mitica circumnavigazione dell'Africa del navigatore cartaginese Annone, né tanto meno la prima circumnavigazione del globo compiuta da Magellano all'inizio del ‘500.
Parliamo di un sentiero di 33 - 35 metri circa, collocato lungo i fossi dei torrenti o in spazi aperti, dove solitario, in un paesaggio formato da molti compagni di lavoro,un singolo lavoratore filava la canapa per trasformarla in spago indispensabile alle reti da pesca. Oppure ci riferiamo a sentieri più lunghi e più ampi dove più lavoratori producevano cime, drizze, gomene per le paranze e le altre barche da pesca, camminando avanti e indietro.
Qui a San Benedetto, i funai sparsi per lo più tra la zona nord della spiaggia e il centro del paese, producevano corde di ogni tipo per ogni uso. La circonferenza della terra misura 40.009,152 Km. e l'umanità conosce questa misura da più di 2000 anni, prima di aver conosciuto i continenti, le viscere dei vulcani, prima che le 5.000 diverse culture delle civiltà umane del pianeta sapessero l'una dell'esistenza dell'altra.
In sette - otto anni circa, calcolando i giorni di freddo e di pioggia, le domeniche e le feste comandate , un funaio, compiva il suo giro del mondo:40.009 Km. di cammino, sempre lungo lo stesso sentiero, percorso andando lentamente all'indietro, dalla ruota al palo, camminando veloce al ritorno . Un'esperienza personale, individuale, vissuta in una situazione collettiva. I funai camminavano solitari e vicini, con intervalli, grida, frasi di vera comunità.
Fu diffusa la pratica di avere uccellini, umili verdoni o più nobili canarini, che accompagnavano il funaio, fermi sulla sua spalla oppure saltellando lungo il sentiero. E' famoso l'episodio di quel funaio che senza volerlo, schiacciò il suo uccellino, che saltellava alle sue spalle e scoppiò in pianto. Camminare è una pratica oggi tornata di moda, come sistema di una percezione perduta del mondo, a causa delle autostrade, dimenticata sugli aerei, nei vagoni dei treni. Ma parliamo di un camminare aperto, dove l'osservazione viene compiuta dallo sguardo del viandante che si sposta lungo la via.
Nel caso del funaio, l'insistenza sui 33 metri, avanti e indietro, indietro e avanti, possiede lo stesso respiro del movimento dei canoni orientali dove il movimento del tempo è una ruota che gira su se stessa in un eterno, continuo ritorno. Sempre le stesse erbe, le foglie uguali del pioppo, il variare del paesaggio nelle stagioni, sempre diverso e sempre uguale di anno in anno. Quel tempo circolare del lavoro veniva riempito intonando canzoni, parlando con il parallelo compagno, con la recita di ritornelli, con storie conosciute, collettive, narrate a se stessi.
La solitudine di fronte al lavoro è una condizione molto diffusa nella fase pre - industriale. Marx dice che il socialismo operaio aveva avuto la sua gestazione e il primo punto di forza (ed il suo limite, dal suo punto di vista) nelle lunghe ore solitarie, passate dagli orologiai svizzeri montando i pezzi degli orologi. La figura del pastore errante, dall'Abruzzo alle steppe dell'Asia ricordate da Leopardi in una delle sue poesie più note e problematiche , ci ricorda come la condizione solitaria nel lavoro pre - industriale fosse una delle fonti di ricchezza delle culture popolari.
C'è una tendenza diffusa e maggioritaria ad attribuire alla condizione del lavoratore pre industriale, solo fatica, abbrutimento e miseria. Si pensi solo alla falsificazione della storia del cibo e della cucina, in base alla quale, le ricette popolari sono sempre prodotte dalla necessità, povertà e scarsità di risorse. Mai figura anche il gusto, la ricerca, le sperimentazioni che, invece, accanto alla povertà, sono sempre state una prerogativa delle classi popolari. C'è del vero, nel descrivere le condizioni di proletari funai, come i più poveri dei poveri, ma quella povertà estrema non esclude affatto la capacità di costruzione di una cultura raffinata e di conoscenze estremamente sofisticate.
2. Il fosso e la spiaggia: l'ambiente culturale collettivo
Il giro del mondo dei funai si dipanava, come la canapa che si trasforma in spago, all'interno di una dimensione collettiva. Il sentiero è la storia di un singolo, il "fosso" e la spiaggia. la piazza o, il capannone, sono i luoghi del sentire collettivo, dove i funai si trasformavano in gruppo sociale con una precisa identità. La dimensione del lavoro pre - industriale produceva una cultura che presenta delle varianti interne, come la fabbrica ha prodotto le culture collettive di massa degli operai.
Innanzitutto ad una cultura materiale. Chi ricorda la mostra Mare di Corda (1999) o chi vede le foto degli strumenti usati dai funai, dai canapini, o la linguetta delle retare, comprende subito di trovarsi di fronte ad oggetti che possono sembrare semplici e che, al contrario, richiedono grandi artigiani e grande abilità nell'uso. E già troviamo negli strumenti di lavoro la base di una cultura tecnica che diventa cultura materiale.
Ma altri fattori producono il mondo di vita dei funai: il palaferro, lu buche de lu palaferro e l'arte di piantarlo "battere") nel silenzio dell'alba, la rote, lu bankò de la rota, la linetta, lu ‘arzò, lu cerchiò, la corda, jpere, le girelle, lu mezzule, la pezza, i crastie, lu crocette, lu torte, la femette, lu naspette, na sfuriate.
Il funaio era un metereologo dalla cultura dell'osservazione. Come per i marinai, prevedere pioggia, tempeste e caldo afoso, era una questione vitale.
Poi c'era la cultura della comunità. Se i marinai furono l'emblema della città , fino a stendere sull'intera società locale lo specchio del mare nel linguaggio, nelle storie, i canapini ed i funai furono l'anima profonda e nascosta della città, l'impalcatura invisibile che sosteneva la comunità: le barzellette, gli sfottò, i soprannomi, e soprattutto le storie di paese, i pettegolezzi.
I funai furono portatori di un codice rigorosamente orale, narrato in modo aperto con varianti infinite e soprattutto con una morale popolare, fondata su valori umani ed anche sui pregiudizi del buon senso. Una morale popolare che stava cucita nelle storie come le tasche interne delle giacchette dove si mettono i portafogli o i documenti di identità.
3. La tecnologia dell'abilità estrema e la forza dei rapporti deboli
Nella opera più famosa sulle tecnologie e le conoscenze della storia europea recente, L'Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri, di Diderot e D'Alambert, scritta a metà del ‘700, molte illustrazioni spiegano le tecniche raffinate usate dai produttori di corde, reti, trappole. Più o meno quelle tecniche dal Settecento ai funai di cinquanta anni fa, rimangono grosso modo le stesse. Anche le relazioni industriali, come si chiamano oggi i rapporti tra padroni e lavoratori, erano schematicamente simili.
Il funaio era un libero professionista. Un operaio che contrattava il suo compenso ogni sabato mattina alla consegna del lavorato. Ogni volta discussioni e trattativa. Una gabbia o meglio la forza oppressiva dei legami apparentemente deboli. Ma c'erano altri legami labili che avevano un grande peso.
Anche i legami della cultura interna dei funai erano deboli, anche se coinvolgevano la famiglia: l'amicizia, la cantina, le feste organizzate dalle parrocchie o dai sindacati, la posizione politica spesso da tifo meditato, erano i mitici legami deboli che rendevano forti le condizioni della produzione.
Il lavoro richiedeva un'abilità estrema, quanto quella degli orologiai citati prima. La precisione del lavoro iniziava dai canapini, ma si richiedeva anche la capacità di adattare il lavoro alla domanda specifica. Una capacità che nessuna macchina ha mai avuto e che ricompare nel mondo produttivo solo con il computer.
La cultura funara non fu, al contrario di quanto si dice delle culture popolari viste solo come resistenza ai mutamenti, esterna al mondo industriale, ma una dinamica di interpretazione e di adattamento trasfigurato alla società sempre più di massa, anche se pre - consumista.
I funai interpretavano le linee organizzative e di valore che scendevano dal dibattito nazionale. Il momento più significativo di questo rapporto fu la Marcia della fame. La richiesta di assistenza era una richiesta di inclusione nella cittadinanza della società moderna, dove assistenza medica e vecchiaia non possono essere più lasciate alla competenza di istituzioni tradizionali come la famiglia, la comunità, la carità. Quella lotta fu anche il segno della vitalità del mondo produttivo dei funai che era al passo con il dinamismo degli anni cinquanta.
Nel 1952, anno della marcia, per la prima volta nella storia sindacale, segretaria generale dei tessili era una donna. Al Festival di Sanremo vinse Colomba bianca vola: una canzone di rinascita anche se malinconica. La ricostruzione stava entrando in una fase matura con il rilancio dell'economia e l'affermazione del modello Italia, cioè della produzione per export e del lavoro a bassi salari, si stava affermando. De Gasperi avrebbe voluto che la nuova Italia fosse formata da un popolo laborioso, risparmiatore, parco, con pochi soldi e vita dura. Lo chiamò un popolo di formiche.
La sinistra metteva in evidenza il carattere anti popolare della crescita. Noi nel 1968 ci abituammo chiamare qul periodo La lunga notte degli anni Cinquanta. Le cose non stavano propriamente così, perché anche nella povertà, nei bassi salari, nel lavoro artigiano senza orario, nelle opportunità di piccolo cabotaggio, c'era il segno di una vita che a piccoli passi migliorava e un dinamismo della società italiana nel quale molti, anche di sinistra, riconoscevano se stessi, pur marciando contro il governo.
Il risultato fu un paradosso "dolce": lotte forti, un isolamento della classe operaia delle grandi fabbriche da una parte e la grande capacità di mobilitazione per i diritti di cittadinanza, dall'altra. La modernità e lo sviluppo del miracolo economico, erano più riposte in queste ultime che non nella politica delle lotte politicizzate. Anche in questo i funai furono cultura avanzata.
4. La fine del sentiero
Il sentiero aveva una fine e la società dei funai anche. Furono i nuovo materiali sintetici a decretare la morte di un'industria diffusa e pre - industriale per organizzazione e cultura. Molti funai si trasformarono in una delle figure più comuni dell'Italia di allora: gli emigranti. Esportavamo braccia e De Gasperi, allargando le sue braccia esclamò in una riunione, divenuta celebre per la sua frase "Meglio emigranti che briganti" Molti funai andarono in Belgio. C'era un trattato tra quel paese e il nostro che prevedeva un tot di approvvigionamento di energia per le nostre industrie per ogni italiano minatore.
Oggi tutti noi, viviamo in un mondo che non avevamo previsto e parliamo del nostro passato: diverse appaiono le poste di oggi al pensionato postino, diversa la scuola chi passeggia sul lungomare, ma solo i canapini, i funai e le retare fanno riferimento ad un mondo perduto, ad una civiltà del lavoro favolosa e lontana come le sette città d'oro di Cibala.
Eppure in quel mondo ci sono contenuti che andrebbero riscoperti come elementi utili a tutti noi per affrontare con maggiore responsabilità e migliore perizia, la post modernità. La società liquida, come dice Bauman o la società del rischio, come dice Beck, la folla solitaria di Riesman, l'anomia della globalizzazione : Insomma tutte le definizioni del mondo di oggi, indicano una situazione di legami deboli, di carriere competitive e solitarie, di precariato, di ricerca di protezione.
La comunità locale può fornire una risposta parziale producendo una cultura unitaria, nascosta tra le pieghe della sabbia o oppressa dal cemento, che faccia da mediazione alla post- modernità. Esattamente una cultura che funzioni oggi come quella dei funai di un tempo: un'anima profonda della città, un senso del luogo.
|
|
03/02/2008
Altri articoli di...
Cultura e Spettacolo
Una serata di emozioni e scoperte (segue)
Il Belvedere dedicato a Don Giuseppe Caselli (segue)
TEDxFermo sorprende a FermHamente (segue)
53 anni di Macerata Jazz (segue)
Il recupero della memoria collettiva (segue)
Giostra della Quintana di Ascoli Piceno (segue)
A RisorgiMarche il Premio "Cultura in Verde" (segue)
Porto San Giorgio torna a gareggiare al Palio dei Comuni (segue)
San Benedetto
Una serata di emozioni e scoperte (segue)
Studenti omaggiano il Milite Ignoto (segue)
Samb: Serafino è il nuovo presidente! (segue)
Istituto Professionale di Cupra Marittima: innovazione a tutto campo. (segue)
Open Day a Cupra Marittima, al via il nuovo corso Web Community – Web Marketing (segue)
GROTTAMMARE - ANCONITANA 1 - 3 (segue)
SAN MARCO LORESE - GROTTAMMARE 1 - 0 (segue)
UGL Medici:"Riteniamo che gli infermieri e i medici debbano essere retribuiti dalla ASUR5" (segue)
Le strade musicali dell'Ebraismo nel compendio cinematografico di David Krakauer

Una serata di emozioni e scoperte

Betto Liberati