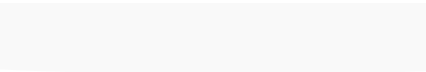Figure del Sacro
| LORETO - Rappresentazioni della devozione, del pellegrinaggio e della religiosità popolare nella fotografia italiana
di Paolo Morello
La devozione, il pellegrinaggio, la religiosità popolare sono stati uno dei temi più rappresentati nella fotografia italiana dalla fine della seconda Guerra mondiale in avanti. Non c’è fotografo, tra i nostri migliori, che non abbia prodotto su questi motivi opere di qualità straordinaria: Mario Giacomelli, Gianni Berengo Gardin, Mario De Biasi, Enzo Sellerio, Ferdinando Scianna, Piergiorgio Branzi, Pepi Merisio, Alfredo Camisa, Franco Pinna, Federico Patellani, Tazio Secchiaroli, Carlo Bevilacqua, e l’elenco potrebbe per molte altre voci ancora andare avanti.
Non troviamo uguale interesse tra i fotografi dell’Ottocento e della prima metà del Novecento. Questo, almeno, fino ad oggi le nostre conoscenze ci avevano indotto a pensare. E questo fatto poneva allo storico un problema di non immediata interpretazione, in quanto il sentimento religioso e la partecipazione delle masse ai rituali hanno rappresentato uno dei temi più costanti e più peculiarmente identitari della cultura dell’Italia post-unitaria. Si può intendere questo silenzio come una temporanea lacuna documentaria, o interrogarsi sull’improvviso esplodere di un’attenzione inedita nei primi anni Cinquanta; l’una cosa non esclude l’altra, e rimane l’urgenza di interrogarsi.
Possiamo provare ad intendere lo scarso interesse del fotografo ottocentesco in ragione della scarsa commerciabilità di queste immagini. In un mercato, com’è quello del secolo XIX, fortemente orientato verso il souvenir di viaggio, il vedutismo, la rappresentazione del patrimonio architettonico e monumentale: che viveva, in somma, ancora nel solco della cultura del Grand Tour settecentesco, la cui eredità era tutt’altro che estinta; entro questa cultura, l’attenzione per i rituali del pellegrinaggio e della religiosità popolare a fatica rientrava. Negli anni precedenti la prima Guerra mondiale, e poi, con forza ulteriore, durante il ventennio fascista, lo scarso interesse dei fotografi per la religiosità popolare può esser letto alla luce dei tentativi, solo in parte riusciti, di instaurare anche in Italia, sul modello di quanto era stato tentato già nella Francia rivoluzionaria, una ‘religione laica’: ossia di trasferire sulla Patria, sul culto dei caduti ed infine del Duce quel ‘bisogno di religiosità’ che, nella cultura occidentale, si era tradizionalmente identificato nella tradizione cristiana. Il dannunzianesimo, la ‘immaginifica’ produzione di slogan e di rituali, come bene ha osservato George Mosse, e quanto poi dell’esperienza dannunziana passò al ritualismo fascista, diedero un contributo determinante in questa direzione. Possiamo intendere entro questo contesto le ragioni per cui non troviamo, negli anni tra le Guerre mondiali, molta documentazione fotografica sulla religiosità popolare, mentre, di contro, troviamo molteplici testimonianze dei rituali politici: adunate, folle oceaniche.
La copiosa documentazione fotografica che ora, per la prima volta, riaffiora dalle collezioni della Santa Casa di Loreto, e che si pubblica in occasione di questo catalogo, induce a riconsiderare, almeno in parte, quel modello di interpretazione, che per molti anni abbiamo dato per assodato. Si tratta di molte centinaia di scatti, presi sin dagli anni Venti da diversi fotografi locali, i cui nomi ci rimangono ignoti o che, comunque, fatichiamo a riferire a precisi dati biografici. Ma, al di là del bruto dato quantitativo, si tratta di una documentazione sotto molti aspetti di un’importanza straordinaria.
L’evidenza più sensibile ed immediata, che si ricava da queste immagini, è, prevedibilmente, di natura etno-antropologica. Potere osservare gli abiti, le calzature (o i piedi scalzi), i copricapi, le valigie (o i cartoni annodati di spago), offre elementi preziosi per una riflessione sulla provenienza sociale, la persistenza di costumi, posture, ma anche di forme di aggregazione, che il pellegrinaggio origina o trae da altri, più antichi rituali. Questa imponente massa di dati è offerta allo studioso di scienze sociali con l’immediatezza caratteristica della fotografia, senza il filtro di convenzioni rigidamente stereotipate. Si può, naturalmente, andare oltre, ed osservare le stesse testimonianze da differenti angoli di visuale. Ad esempio, si possono studiare queste fotografie nella prospettiva della storia sociale dei trasporti, perché ogni pellegrinaggio implica, in primo luogo, una mobilitazione e un trasferimento di masse. Epperò ancora nasce spontanea la curiosità di sapere per quali scopi, per quali pubblici, queste fotografie siano state scattate. Se fossero oggetto di un commercio, di un qualche mercato, anche se appare davvero improbabile che gli stessi pellegrini avessero l’abitudine di acquistare come ricordo delle immagini in cui apparivano sofferenti e scalzi. Bisognerebbe discernere caso per caso.
A ciascuna di queste osservazioni, queste fotografie offrono un contributo importante. E tuttavia si ha la sensazione che a guardare queste testimonianze con gli occhi dello scienziato sociale si manchi il loro senso più profondo e importante.
Nella storia delle arti — particolarmente in Italia, ove il retaggio crociano è ancora estremamente vitale — inevitabilmente si finisce col cadere nella misurazione della ‘temperatura estetica’ di ogni testimonianza, nella distinzione tra arte e non-arte. Tanto più in fotografia, la cui vocazione alla riproduzione obiettiva, non mediata, sebbene discenda da luoghi retorici totalmente opinabili, è tuttora assai ben radicata. È proprio tale distinzione che, paradossalmente, queste fotografie mettono in scacco.
Torniamo al fiorire di fotografi che, dalla fine degli anni Cinquanta, dedicarono alla rappresentazione del Sacro, del pellegrinaggio e della religiosità popolare, una parte nient’affatto marginale della loro attività. Qualsiasi fosse il loro orientamento politico, la loro formazione, la committenza per cui lavoravano. È naturale che ciascuno di loro affrontasse la questione da una prospettiva particolare — ed, anzi, è proprio questo intrecciarsi di istanze e di prospettive particolari a rendere questo insieme di opere tanto straordinario. Tra quei fotografi, c’erano tanti cattolici quanti erano i laici, ancorché la critica abbia dato sempre a questi ultimi maggiore risalto.
Non vi furono, in apparenza, ragioni esterne a scatenare un interesse tanto vivace: possiamo solo congetturare. Certo l’esperienza della Guerra e della Resistenza avevano alimentato un bisogno di umanità, un ritorno a sentimenti meno bestiali. Certo la fortuna delle opere di Antonio Gramsci contribuì molto a risvegliare l’interesse degli intellettuali per la cultura popolare (Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce, il primo di molti volumi tratti dai Quaderni dal carcere, venne pubblicato da Einaudi nel 1948, a undici anni dalla sua morte; Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, apparve l’anno seguente, 1949). E tuttavia sarebbe errato ridurre la fortuna della religiosità popolare ad una moda, ad uno dei temi topici di quel gusto che, con un termine orribilmente abusato, prende in genere il nome di ‘neorealismo’ fotografico.
La tesi, che in queste pagine si vuole affermare, è che la rappresentazione fotografica del pellegrinaggio, del Sacro, della religiosità popolare, trascendano l’urgenza documentaria dell’etno-antropologo così come travalicano il carattere ‘convenzionale’ dell’espressione realista. Ma rispondono, in modo più profondo, e in tanto più contraddittorio, al bisogno di investigare, anche in forma dubitativa, anche in forma polemica, uno degli elementi primari sui quali la nostra cultura, diciamo quella occidentale, ha fondato la sua identità. E se fotografia è investigazione sull’uomo, essa non potrà sottrarsi dal considerare, dell’uomo, quegli aspetti costitutivi, astorici e atemporali, come il bisogno del Sacro.
In ordine di tempo, fu il milanese Federico Patellani uno tra i primi ad interessarsi, alla fine degli anni Quaranta, della religiosità popolare. A quella data uno dei maggiori fotoreporters della rivista “Tempo”, Patellani fu autore, nel corso di innumerevoli viaggi nel Sud Italia, di straordinari servizi fotografici sulla sopravvivenza di pratiche magiche, divinazioni nello stagno fuso, esorcismi ed altri rituali in cui elementi di una antica religiosità pagana si mischiavano a simboli propri della tradizione cristiana. Negli stessi anni, 1952-1960, il fotografo Franco Pinna prese parte ad una serie di spedizioni in Puglia e in Lucania, guidate dall’etno–antropologo Ernesto de Martino, e volte a documentare, anche attraverso le immagini, pratiche quali il pianto rituale, il tarantolismo, o riti di fecondità e cerimonie di propiziazione del raccolto. Fu nel corso della ricerca sul lamento funebre, che Pinna prese una delle sue fotografie più mirabili: a San Fele, al pellegrinaggio al santuario della Madonna di Pierno, il 15 agosto 1956. All’interno della chiesa, riprese un gruppo di donne e di bambini fermi di fronte all’altare: sui loro volti, un misto di attesa e terrore. Poche altre fotografie sanno rendere con altrettanto vigore quell’idea di religiosità popolare che, nel senso etimologico, è soggezione, legame che incute terrore.
Mentre Patellani guardava i riti magici con molto distacco, con la divertita sufficienza di un altoborghese che da Milano si spinge fino a Benevento per fotografare dei riti che soltanto in un’altra epoca o in un altro mondo avrebbe potuto immaginare, Pinna era un militante comunista (qualche anno prima era finito in galera per volantinaggio non autorizzato): dava sempre ai contadini che fotografava — da un punto di vista volutamente basso — un’aura eroica, monumentale.
Negli stessi anni, ma da una prospettiva opposta, Pepi Merisio realizzò uno straordinario réportage intitolato Pellegrini al mio santuario: quello di Caravaggio, il paese dov’era nato. Merisio era giunto alla fotografia professionale dopo aver conseguito una laurea in filosofia all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano — fatto piuttosto insolito, per quegli anni. E per molti anni ancora, avrebbe collaborato con il Touring Club Italiano, producendo diecine di eccellenti libri sul paesaggio; poi sarebbe diventato il fotografo ufficiale di papa Paolo VI: uno dei suoi più famosi servizi, Una giornata col papa, apparve sulla rivista “Epoca” nel 1964, mentre sulla rivista svizzera “du” venne pubblicato il suo, celeberrimo, numero monografico sul Vaticano. Se, da un lato, la sua professione lo spingeva verso rappresentazioni ‘ufficiali’, dall’altro lato il suo cuore, e le sue fotografie più mirabili, sarebbero rimaste legate alla religiosità popolare, al santuario di Caravaggio, ai pellegrinaggi al Monte Autore, nel Lazio.
Tra le fotografie prese nel 1956 a Caravaggio, una, in particolare, cattura la nostra ammirazione: mostra un’anziana donna su una sedia a rotelle, vestita di nero, con un velo nero sul capo. Prega. Ha gli occhi socchiusi. Punta la destra contro il petto; nella mano sinistra tiene stretto un rosario. Ha la pelle increspata di rughe, i tratti affilati: il naso tagliente, le dita tese, quell’espressione di compostezza severa che soltanto sul volto di certi lombardi si può ancora trovare. Accanto, una donna più giovane rivolge alla Madonna uno sguardo pieno di speranza; sulle ginocchia tiene un bambino che, s’intuisce appena, si agita in uno spasmo. La forza di questa fotografia discende, in primo luogo, dall’autenticità della scena. La religiosità popolare non è un tema sul quale alcuna connivenza estetizzante tra il soggetto e il fotografo possa funzionare. In tal senso, la rappresentazione del Sacro sfida le convenzioni del Realismo pittorico e letterario: sfugge a qualsiasi possibilità di ricerca formale. Inevitabilmente esistono, per ogni fotografo, modelli figurativi ai quali rifarsi, nel ritrarre un contadino, un paesaggio, un attore o il dolore. Ma non si riuscirebbe a rappresentare, con autentica intensità, la devozione popolare ricorrendo a formule stereotipate.
Merisio occupa un posto del tutto eccezionale nella storia della rappresentazione del Sacro. Poiché è il fotografo che, più di ogni altro, ha saputo fondere ragioni autobiografiche a cura professionale. Se, tutte le volte che può, Merisio ritorna tra le valli della natìa bergamasca, è per l’urgenza di verificare, tra i suoi contadini, le radici di quei valori che, da cattolico, aveva scelto di praticare. È il bisogno di ritrovare, ancora intatto, il mondo ov’è nato e al quale ha scelto consapevolmente di continuare ad appartenere; un mondo che quei tempi di cambiamento minacciavano di fagocitare. A Milano, il tumulto del ’68 dilaga.
Così, per Merisio ogni scatto diventa non già la prova di una esistenza, ma di una resistenza. Fotografare lo zio sul catafalco (In morte dello zio Angelo, un altro dei suoi più celebri réportages), la gente del paese che si raccoglie intorno alla salma, il composto funerale, non è constatazione di morte, ma di sopravvivenza. Di un modo di vivere, di un bisogno primario. Nel reiterarsi di questa riprova — l’esperienza del Sacro come capacità di durata —, Merisio cerca un lenitivo spirituale: il suo interesse non potrà mai esser ridotto a mera curiosità sociologica, politica, o culturale. Come un altro grande fotografo a lui contemporaneo, il senigalliese Mario Giacomelli, Merisio racconta con fotografie come queste la sua gente, il popolo al quale sente di appartenere. Come Giacomelli, non esita a mettersi in gioco: lo fa d’istinto, con disincanto, per assecondare un’urgenza esistenziale. Ciò che gli importa rendere manifesto, del soggetto che ritrae, è il sentimento di solidarietà che da esso promana, e al quale il fotografo stesso rivendica di partecipare.
È in questa chiave che possono, a nostro avviso, essere lette e correttamente intese le fotografie dei pellegrinaggi a Loreto, alla Santa Casa. Nel segno di una identificazione totale, di un coinvolgimento, anche emotivo, tra il fotografo e quell’universo di umanità che, nel pellegrinaggio, si autosospende dal tempo; che, nella sua ricerca del Sacro, decide di porsi, temporaneamente, fuori dalla storia. È in questo miracoloso frangente che la fotografia — arte, così si dice, dell’istantaneità — si fa interprete di un tempo assoluto, eterno. Ineffabile.
|
|
31/03/2006
Altri articoli di...
Fuori provincia
04/04/2025
Una serata di emozioni e scoperte (segue)
Una serata di emozioni e scoperte (segue)
14/11/2022
Terremoto: subito prevenzione civile e transizione digitale (segue)
Terremoto: subito prevenzione civile e transizione digitale (segue)
14/11/2022
Il presidente di Bros Manifatture riceve il premio alla carriera "Hall of Fame/Founders Award" (segue)
Il presidente di Bros Manifatture riceve il premio alla carriera "Hall of Fame/Founders Award" (segue)
02/11/2022
Glocal 2022: dove i giovani diventano protagonisti del giornalismo (segue)
Glocal 2022: dove i giovani diventano protagonisti del giornalismo (segue)
02/11/2022
Sisma 2016: approvati 15 mila contributi per 4.8 miliardi (segue)
Sisma 2016: approvati 15 mila contributi per 4.8 miliardi (segue)
27/10/2022
A Cartoceto, nelle ‘fosse dell’abbondanza’ per il rituale d’autunno della sfossatura (segue)
A Cartoceto, nelle ‘fosse dell’abbondanza’ per il rituale d’autunno della sfossatura (segue)
27/10/2022
Il Comune pulisce i fossi Rio Petronilla e via Galilei (segue)
Il Comune pulisce i fossi Rio Petronilla e via Galilei (segue)
27/10/2022
TEDxFermo sorprende a FermHamente (segue)
TEDxFermo sorprende a FermHamente (segue)
ilq


Le strade musicali dell'Ebraismo nel compendio cinematografico di David Krakauer

David Krakauer
"The Big Picture"
Una serata di emozioni e scoperte

ASPIC Psicologia di San Benedetto del Tronto presenta il Centro Psiconutrizionale
Betto Liberati